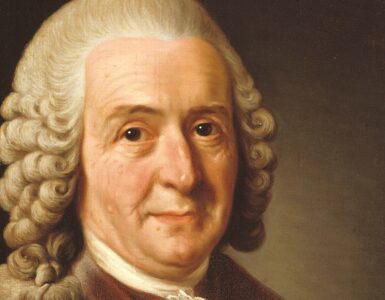Il titolo non inganna, è proprio così che stanno le cose: nella Spagna del XVII secolo mangiare fango era considerata una pratica alla moda, che oggi definiremmo con l’inglesismo “cool”. Sembra un’assurdità, lo capisco, ma seguitemi nel seguente ragionamento e presto comprenderete la mentalità di quelle persone che nei secoli addietro credettero che la buccherofagia (ingerire frammenti di ceramica) o la geofagia (idem ma con la terra) fossero la risposta a tutto.

Mangiare fango, che bontà! Ma se lo si faceva, era perché, soprattutto in specifiche corti dell’Europa occidentale, bisognava rispettare un certo canone di bellezza. La questione non è solo del Seicento, e non è pertinente soltanto alla Spagna imperiale. Per secoli, l’ideale di bellezza femminile ha associato la carnagione chiara alla nobiltà e al privilegio sociale. Avere la pelle pallida non significava soltanto rispondere a un canone estetico, ma anche segnalare la lontananza dalle fatiche manuali e dal sole dei campi. Nella Spagna del Siglo de Oro, questo ideale trovò una sua declinazione estrema. Estrema poiché le dame di corte, nel tentativo di mantenere un incarnato niveo, arrivarono a ingerire acqua e terra.
Non si trattava però di una pratica improvvisata. Il fango era quello cotto e modellato nei cosiddetti buccheri, recipienti di argilla usati per contenere l’acqua, in particolare quelli provenienti dal Portogallo, molto rinomati. L’impasto veniva aromatizzato con erbe essiccate e macinate, così da conferirgli un profumo peculiare che impregnava anche l’acqua custodita nei vasi. Da lì nacque l’abitudine di ingerirne piccoli pezzi. Abitudine che si fece presto moda, moda che si diffuse tra nobildonne iberiche e lusitane. Di lì a poco, avrebbe attraversato l’Atlantico, approdando nelle esotiche residenze vicereali d’America.

Ora, ve lo dico, è necessario che si inquadri la buccherofagia (termine trasposto dallo spagnolo bucarofagia) come un fenomeno circoscritto, oltre che liminale fra la medicina e la superstizione. In che senso? Bene, la pratica era circondata da credenze mediche e superstizioni contraddittorie. Al marchese di Harcourt, in visita a Madrid nel 1698, fu riferito che mangiare fango poteva ostacolare la capacità riproduttiva. Al contrario, i medici prescrissero la stessa sostanza alla regina Maria Luisa d’Orléans, moglie di Carlo II d’Asburgo (lo stregato per capirci), nella speranza che favorisse il concepimento e risolvesse la drammatica questione della sterilità reale.
Gli effetti fisiologici della buccherofagia erano tutt’altro che benigni. Madame d’Aulnoy, turista francese in Spagna negli anni ‘Ottanta ’80 del Seicento, descrisse con sguardo quasi etnografico le signore madrilene che masticavano pezzi di argilla. Esse erano gonfie, dure nello stomaco e con il colorito giallastro, “come mele cotogne”. Per contrastare questi sintomi, si raccomandava loro di bere molta acqua “ferruginosa”, le celebri acque ricche di ferro della Casa de Campo a Madrid, note come “acque d’acciaio”.

Il fenomeno era talmente diffuso da trovare ampia eco nella letteratura e nel teatro. Gli storici hanno parlato di “oppilate”, termine con cui venivano definite le donne che, a causa del fango ingerito, soffrivano di gonfiori e irregolarità digestive.
Il drammaturgo Lope de Vega dedicò all’argomento un’intera commedia, El acero de Madrid (1608). Qui, la protagonista Belisa finge di essere oppilata per nascondere una gravidanza, inscenando il rituale del consumo di buccheri seguito da una passeggiata verso le fontane di Madrid, dove avrebbe dovuto bere l’acqua d’acciaio. Nella stessa opera circolava anche un canto popolare:
«Fanciulla dal colore disfatto,
o sei innamorata, o mangi fango».
L’argilla compare anche in altre opere dello stesso autore, come La Dorotea (1632), dove si distingue addirittura tra i buccheri portoghesi e quelli di Garrobillas, in Estremadura. Non mancavano riferimenti eruditi. Lope si informava attraverso testi come il Diálogo del hierro y sus grandezas, redatto nel 1574 da Nicolás Monardes, che collegava ferro, salute e oppilazione.

Anche scrittrici come María de Zayas ripresero la figura delle oppilate, ad esempio nel racconto Aventurarse perdiendo, dove la malattia della protagonista è letta come effetto della perdita di colore e dell’eccesso di fango. Il tema divenne materia di satira per Francisco de Quevedo. Egli ironizzò sugli incontri clandestini tra oppilate e gentiluomini diretti alle fontane di Madrid “a bere l’acciaio”. In un suo epigramma, ridicolizza una donna che, con la scusa del fango e delle cure, finisce solo per consumare la fortuna del suo amante.
Non è che nessuno criticasse la moda di mangiare fango, ci mancherebbe. Il cronista Juan de Zabaleta nelle sue opere pose l’accento sull’insensatezza della buccherofagia, intesa non solo come una stravaganza, ma anche come un peccato, un simbolo di vanità e dissolutezza.

Ciò che oggi appare bizzarro – mangiare fango per sbiancare la pelle – riflette in realtà tensioni profonde. Si dica questo per l’ossessione estetica, l’ansia per la fertilità, la medicalizzazione del corpo e la satira sociale. E sebbene la moda dei buccheri sia tramontata con la fine del Seicento, la pratica di ingerire argilla o terre minerali non è scomparsa. Sopravvive ancora in alcune culture africane e in tradizioni popolari contemporanee, come un filo sotterraneo che collega la corte di Madrid del Siglo de Oro a riti ancestrali diffusi in altre parti del mondo.