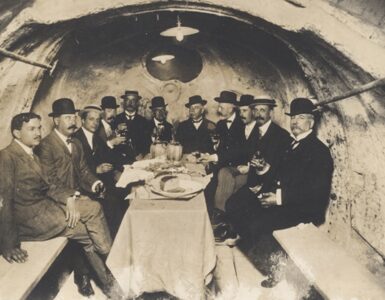Fotografia di Yuri Belinsky, Giardino d’Estate di Leningrado (San Pietroburgo), Russia, 20 novembre 1976. Spalle alla macchina fotografica, cappello in testa e un lungo cappotto nero, incorniciato da una luce fioca e da alberi spogli che disegnano ombre sfumate sullo sfondo. Lui procede lentamente, accompagnato dai fedelissimi amici a quattro zampe, lungo uno dei suggestivi viali del Giardino d’Estate, luogo di ritrovo e svago in quel di San Pietroburgo, all’epoca dello scatto ancora Leningrado. L’uomo, anonimo nell’aspetto e nel portamento, è in realtà il soggetto di un apposito servizio fotografico. Chi era, dunque, per meritarsi tali attenzioni fotografiche? Per campare faceva il clown e tutti, al di là della Cortina di Ferro, lo conoscevano col nome di Karandaš.

Nato nel 1901 in una vivacissima San Pietroburgo, Michail Nikolaevič Rumjancev fu una delle figure più emblematiche del circo sovietico del XX secolo. Il suo nome d’arte, Karandaš, significa “matita” in russo, e venne scelto per evocare la sua figura sottile e il suo stile caricaturale, oscillante fra la comicità più genuina e la critica sociale più sottile. Una carriera, la sua, che si dipanò per oltre cinquant’anni. Durante il mezzo secolo non solo conquistò le arene di tutta l’URSS, ma formò anche una nuova generazione di artisti circensi. Un maestro per loro, un idolo per tante, tantissime giovani generazioni.
Ancora per rimarcare il profilo caratteriale di Karandaš – aspetto non secondario quando si cerca di inquadrare un uomo che fece del personale modo di porsi la sua professione – venga qui specificata la sua innata capacità di cogliere con sagace ironia alcuni aspetti del contesto in cui visse e lavorò.

Nella Russia dei soviet, il clown rappresentava spesso un veicolo sottile di satira e riflessione sociale. Basta osservare i suoi numeri: Rumjancev interpretava personaggi che deridevano la burocrazia, la meschinità quotidiana e i difetti umani. Tuttavia manteneva sempre un tono delicato e accettabile, così da compiacere la censura comunista. La sua comicità era elegante e malinconica al contempo. Parlava tanto ai bambini quanto agli adulti, spesso colpiti dalla profondità umana dietro la maschera.
Facciamo un passo oltre e cerchiamo di comprendere le circostanze entro le quali Yuri Belinsky scattò la fotografia. Il fotografo si era scontrato più volte con le difficoltà di immortalare il clown durante le sue esibizioni. L’artista, geloso della propria immagine e probabilmente stanco dell’attenzione mediatica, tendeva a porre limiti stringenti ai fotografi.

Eppure, incredibile a dirsi, tra i due nacque un fragile accordo: un servizio fotografico informale in un luogo pubblico a lui caro. Fu così che si incontrarono nei Giardini d’Estate di Leningrado, uno dei parchi più antichi e raffinati della città, legato alla memoria imperiale e – a voler cercare forzosamente il lato emotivo dietro la scelta dello scenario – per questo carico di una suggestione malinconica.
Lo scatto di Belinsky attrae per la sua ricercatezza compositiva, per gli spazi e la scelta stilistica. Guardate l’immagine, guardate come la figura minuta del clown russo si staglia al centro dell’inquadratura con un’evidente simmetria. Il tutto mentre i due cani ai suoi lati (come due sentinelle, mi verrebbe da pensare) accentuano la verticalità e la staticità della scena. Poi il bianco e il nero fanno quello che il bianco e il nero fanno di solito: accentuano il senso di riflessione, calandoci in un’atmosfera profonda ma non distaccata.

Il vero colpo d’occhio sta nel contrasto tra la figura pubblica dell’uomo, riconosciuto in tutto il blocco est come simbolo di gioia e risate, e la sua immagine privata. L’immagine di un anziano signore che cammina in silenzio con i suoi animali. Una sorta di “commiato” silenzioso alla vita pubblica, ai sorrisi e agli applausi. È proprio questo equilibrio tra verità e rappresentazione che ha reso lo scatto memorabile, tanto da vincere il riconoscimento al World Press Photo del 1978.