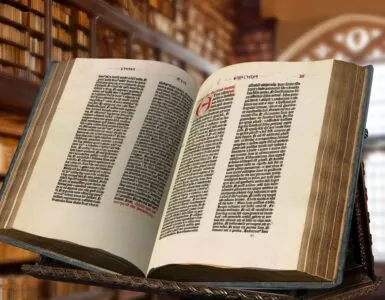Almanacco del 19 novembre, anno 936: su diretta richiesta di ʿAbd al-Rahmān III, primo califfo di Cordova, inizia la costruzione di ‘Madīnat al-Zahrāʾ, letteralmente “la città splendente”. La sontuosa residenza califfale ai piedi della Sierra Morena, in Spagna, sarebbe dovuta essere il simbolo della nuova dignità califfale, nonché uno dei progetti architettonici più eccelsi del Medioevo. Seppur con le dovute precauzioni storiche e basandosi esclusivamente sui documenti progettistici, si può paragonare Madīnat al-Zahrāʾ alle ben più blasonate regge di Versailles, Caserta, o alla città di San Pietroburgo, nata ex novo per volere dello zar Pietro il Grande.

Secondo le cronache andaluse, dopo mesi di preparativi e consultazioni, i cantieri per l’ambiziosa realizzazione di ‘Madīnat al-Zahrāʾ vennero avviati il 19 novembre del 936. Il periodo non è casuale, perché è a quegli anni che si fa risalire l’apogeo della Cordova califfale.
ʿAbd al-Rahmān III (889-961), che nel 929 si era proclamato califfo di Cordova, rompendo formalmente con l’autorità abbaside di Baghdad e con quella fatimide del Cairo, sentì la necessità di dotarsi di una nuova capitale che fosse degna del suo rango e capace di incarnare la potenza e la legittimità del nuovo califfato occidentale, di discendenza omayyade però. Madīnat al-Zahrāʾ non doveva essere una semplice residenza reale. Essa doveva rappresentare l’ordine cosmico e politico dell’impero, un microcosmo di armonia, bellezza e potere assoluto.

Le fonti andaluse raccontano che la città prese nome da al-Zahrāʾ, “la splendente”, che la tradizione identifica talvolta come una delle concubine predilette del califfo. Altri scritti – una minoranza tuttavia – associano il nome all’epiteto riferito alla perfezione e alla purezza dell’Islam stesso. In ogni caso, il nome evocava una luce nuova, quella della rinascita omayyade in Occidente dopo la caduta della loro dinastia in Oriente.

La costruzione di Madīnat al-Zahrāʾ fu una delle imprese più colossali del mondo medievale, cristiano come musulmano. Vi lavorarono oltre 10.000 operai, capaci di posare fino a 6.000 blocchi di pietra al giorno, trasportando materiali con 1.500 animali da soma. Si impiegarono enormi quantità di gesso e calce, e il cantiere rimase attivo per decenni.
Il progetto urbanistico, di straordinaria modernità, prevedeva una pianta rettangolare di circa 1.500 per 750 metri disposta su tre terrazze degradanti verso la valle del Guadalquivir. Anche la scelta di costruire alle pendici della Sierra Morena non fu frutto del caso. Nelle idee della corte califfale, la città, visibile da grande distanza, doveva apparire come un miraggio.

I mastri costruttori concepirono Madīnat al-Zahrāʾ come una città nuova, razionale e monumentale. Senz’altro in contrasto con l’antica Cordova, dal tessuto urbano fitto e irregolare. La sua organizzazione ortogonale, la presenza di una rete idrica e fognaria pianificata e la divisione funzionale degli spazi la rendono una delle prime città progettate integralmente nel Mediterraneo medievale.
Tra gli edifici più celebri spicca il Salón Rico di ʿAbd al-Rahmān III, la sala delle udienze ufficiali. Costruito tra il 953 e il 957, rappresentava il cuore cerimoniale della città. Decorato con pannelli di marmo scolpito, motivi floreali e geometrici, iscrizioni in caratteri cufici, il Salón Rico si distingueva per una pianta basilicale a tre navate, un’innovazione assoluta nell’architettura islamica, che rimandava volutamente alla monumentalità delle basiliche cristiane ma reinterpretata in chiave moresca. Il califfo vi accoglieva ambasciatori e delegazioni straniere, tra colonne di marmo colorato e giochi di luce riflessi dalle piscine e dai giardini.

Complessivamente, la città contava oltre 4.000 colonne, provenienti in parte da spoliazioni romane e bizantine, e poteva ospitare fino a 12.000 persone. Ogni pietra, ogni decorazione, ogni proporzione era concepita per glorificare l’autorità del califfo, rappresentato come “ombra di Dio sulla terra”. Ecco in cosa consisteva l’ardore del progetto datato 19 novembre 936.
La gloria di Madīnat al-Zahrāʾ fu però di breve durata. Dopo la morte di ʿAbd al-Rahmān III, la città continuò a essere il centro politico del califfato sotto il suo successore al-Ḥakam II, ma già all’inizio dell’XI secolo la situazione mutò drammaticamente. Nel 1010 esplose una violenta guerra civile (in storiografia nota come fitna) che devastò al-Andalus e portò alla caduta della dinastia omayyade. Le milizie berbere, coinvolte nelle lotte interne, saccheggiarono la città e la distrussero sistematicamente. Nel 1013, Madīnat al-Zahrāʾ appariva ormai come un cumulo di rovine.

Nei secoli successivi, il sito venne progressivamente spogliato dei suoi materiali: colonne, marmi e pietre furono riutilizzati per edificare o restaurare edifici nella vicina Cordova. La memoria della città svanì, tanto che nelle cronache medievali essa sopravviveva solo come Qadīmat Qurtuba, “la Vecchia Cordova”, un luogo leggendario nascosto sotto la terra.
Solo nel 1911 Madīnat al-Zahrāʾ venne riscoperta da archeologi spagnoli, dando avvio a una delle più importanti campagne di scavi dell’archeologia andalusa. Da allora, le indagini hanno riportato alla luce solo il 10% della sua superficie originaria (all’incirca 112 ettari). Ma quanto emerso basta a restituire un’immagine grandiosa della città perduta.
Nel 1985, il sito passò sotto la tutela della Junta de Andalucía, che ha proseguito sistematicamente gli scavi e promosso un vasto programma di valorizzazione. Nel 2018, l’UNESCO ha riconosciuto Madīnat al-Zahrāʾ come Patrimonio dell’Umanità. Un riconoscimento caduto esattamente a 1082 anni di distanza da quel 19 novembre 936.