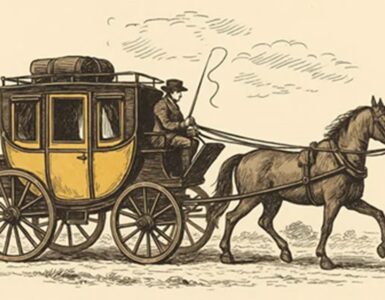Immaginate di essere il doge di Venezia e di dovervi muovere per la vostra città. Mica si possono usare carrozze o portantine, vista tutta quell’acqua e quei canali. Neanche delle gondole normali, in fin dei conti siete pur sempre il leader della città. In effetti il doge, per le occasioni particolari, usava il Bucintoro, la galea di Stato. Fra l’altro era l’imbarcazione che usavano durante il giorno dell’Ascensione nelle celebrazioni del rito dello sposalizio del Mare.
Che cos’era il bucintoro?

Per quanto riguarda il nome, fra le teorie più accreditate c’è quella che deriva dai “bucinatores”, cioè i suonatori di buccina, strumento musicale degli ottoni che già gli antichi Romani suonavano nelle fanfare. Ebbene, proprio i buccinatores suonavano le buccine per avvisare gli abitanti di Venezia dell’arrivo del Doge. Da qui il nome Bucintoro.
Il Bucintoro era utilizzato in diverse cerimonie importanti. Per esempio, sappiamo che nel 1483 il doge Giovanni Mocenigo lo usò per ricevere Renato, il duca di Lotaringia. Nel 1484, poi, fu il Maggior Consiglio della città a decidere di inviarlo per ricevere alcune personalità importanti che stavano arrivando in città per via di un torneo. E fra di essi figuravano Leone, il figlio di Ludovico Sforza, la moglie di Roberto di Sanseverino e Giulio da Camerino, il governatore generale degli armigeri di Venezia.
In realtà, contrariamente a quanto si pensa, il Bucintoro, inteso come vascello cerimoniale, non era certo un’invenzione veneziana. Ne esistevano di molto antichi. Anzi, il Suida ne cita uno nell’Atene di Alcibiade, quindi nel V secolo a.C. E considerate che anche i Savoia avevano fatto costruire il proprio bucintoro.
Ma noi è del Bucintoro di Venezia che vogliamo parlare. Ospitato nell’Arsenale di Venezia, prima fu ormeggiato in un bacino. Solamente in seguitolo misero nella Casa del Bucintor, uno scalo coperto dedicato alla nave. Qui l’imbarcazione era conservata fuori dall’acqua e senza addobbi.

Ovviamente prima di usarlo, bisognava calatafarlo in modo da rendere nuovamente lo scafo impermeabile (onde evitare di vedere il doge colare a picco insieme ai suoi ospiti) e accessoriato nuovamente. Ai remi si trovavano solamente gli operai dell’Arsenale, chiamati Arsenalotti. Il comando, invece, era appannaggio dell’Ammiraglio dell’Arsenale. A prua si trovava l’Ammiraglio del Lido (doveva tenere d’occhio la rotta), mentre a poppa l’Ammiraglio di Malamocco (a lui toccava il timone).
Nel corso del tempo il Bucintoro cambiò forma e aspetto. Quello delle origini era maggiormente piatto ed era trainato a rimorchio. Diverso fu quello del Duecento e poi, successivamente, quello del Trecento. Quest’ultimo aveva due ponti (uno per i rematori e uno per gli ospiti) ed era ricoperto dal tiemo, con le sue aperture laterali. Inoltre era sopraelevata a poppa, proprio dove si trovava il trono ducale. Sulla prua c’era la statua di Venezia raffigurata con le sembianze della Giustizia.
Dal Quattrocento in poi il Bucintoro cominciò ad assumere le caratteristiche che poi mostrerà anche nelle epoche successive. Quello del Cinquecento, per esempio, varato nel 1526, era molto più grande e andò a sostituire quello precedente, ormai sorpassato. Anche questa versione aveva i due speroni prodieri, ma era ancora più riccamente decorato. E aveva il tiemo mobile.
Nel Seicento decisero di costruirne un altro. Varato nel 1606, era più grande e a poppa, in corrispondenza del trono del doge, aveva un tiemo sopraelevato. La prua, invece, non aveva copertura per permettere di esporre meglio le insegne del doge. E c’era sempre la polena a forma di Giustizia.

L’ultimo Bucintoro storico fu quello del Settecento. Varato nel 1729, è quello che maggiormente troviamo nei dipinti dei pittori dell’epoca. Riuscì a sopravvivere alla caduta della Repubblica e all’occupazione francese del 1797, ma i francesi lo distrussero comunque nel 1798, in modo anche da recuperare l’oro delle decorazioni. Trasformarono poi lo scafo in una cannoniera prima e poi in una prigione galleggiante chiamata Hydra.
Attualmente l’unico Bucintoro originale ancora esistente è quello dei Savoia, costruito fra il 1729 e il 1731 nei cantieri navali di Venezia, sono la guida di Filippo Juvarra. Al momento è ospitato presso la Reggia di Venaria di Torino.
In realtà, poi, nel 2004, la Fondazione Bucintoro avviò il progetto per la costruzione di un nuovo Bucintoro. La prima sezione dell’imbarcazione è stata costruita con tronchi di abete, pino rosso e rovere derivanti dalle foreste dell’Aquitania, fra l’altro regalati dalla Francia. Ovviamente la costruzione è avvenuta nei cantieri dell’Arsenale.