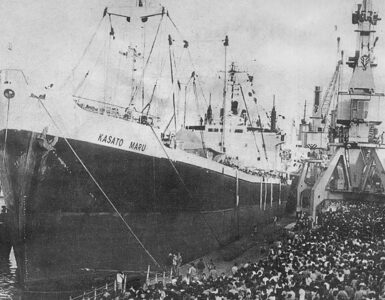Almanacco dell’8 febbraio, anno 1347: termina la guerra civile bizantina, anche chiamata seconda guerra civile paleologa (1341-1347). Prendendo in prestito la definizione della storica bizantinista Angeliki Laiou “dopo la fine della seconda guerra civile, Bisanzio era un impero solo di nome”. Una frase ad effetto che racchiude alla perfezione il senso della catastrofe vissuto dai romei in quel sessennio di metà XIV secolo. L’8 febbraio si registrò l’atto conclusivo del conflitto interno, ma è cosa buona e giusta spendere qualche parola sulla genesi della guerra.

La tensione sfociò in aperta ostilità armata nella tarda estate del 1341, alla morte del basileus Andronico III Paleologo. L’imperatore aveva donato a Costantinopoli una speranza, seppur flebile, di ripresa dopo i torbidi del primo quarto di secolo. Quando egli venne a mancare, il protocollo sulla successione al trono non fu chiarissimo a tutte le figure apicali dell’impero. Secondo la volontà di Andronico, il titolo sarebbe dovuto passare al figlio di nove anni Giovanni V Paleologo. Nel mentre la reggenza sarebbe stata pertinenza di Giovanni Cantacuzeno, fidatissimo consigliere e braccio destro del defunto imperatore.
Liscio come l’olio, vero? Eh no cari amici, perché si posero di mezzo l’imperatrice vedova Anna di Savoia, il patriarca costantinopolitano (che indovinate un po’, si chiamava anch’egli Giovanni…) e il magaduca Alessio Apocauco. Il trio attuò un vero e proprio colpo di stato per instaurare una nuova reggenza, che si frappose a quella del Cantacuzeno. Quest’ultimo rispose a tono, mobilitando esercito e aristocrazia, per lo più a lui fedeli. Al contrario la reggenza autoproclamatasi dopo il golpe era sostenuta dal ceto medio-basso dell’impero. Il Cantacuzeno non era uno sprovveduto e per perorare la sua causa chiese aiuto ad alcuni attori esterni all’intricato gioco bizantino. Noto è il coinvolgimento dei serbi di Stefano Dušan o dei beilicati turchi d’Anatolia.

La guerra civile si trasformò in una mortale contesa fra classi e, come se non bastasse, in un terreno di scontro religioso, visto l’infiammarsi della controversia esicasta (sulla quale non mi soffermerò, promettendo un futuro approfondimento). I primi anni della guerra civile bizantina furono favorevoli alla reggenza tripartita, che riuscì a conquistare ampie zone della Tracia e della Macedonia. Ciò avvenne soprattutto per via delle sollevazioni popolari. Dal 1345 la situazione conobbe un sovvertimento degli equilibri. La riscossa di Giovanni Cantacuzeno (proclamato co-imperatore col nome di Giovanni VI) portò all’uccisione di Alessio Apocauco, vero uomo forte della fazione “golpista”.
Formalmente incoronato come basileus dei romei ad Adrianopoli nel 1346, Giovanni VI Cantacuzeno varcò da vincitore le leggendarie mura teodosiane il 3 febbraio 1347. Cinque giorni dopo, l’8 febbraio, si giunse all’accordo sulla cessazione delle ostilità e ai trattati di pace. Al Cantacuzeno fu riconosciuto il titolo di imperatore anziano (una sorta di via di mezzo fra la reggenza e la dignità imperiale). Coloro i quali si contrapposero alla sua fazione vennero perdonati, ma la grazia non placò gli animi più bellicosi. Da una parte c’era chi voleva rovesciare del tutto i Paleologi (nominalmente restava la dinastia regnante), dall’altra c’era chi non vedeva di buon occhio il riconoscimento dell’autorità dei Cantacuzeni.

Oltre ciò, i termini della risoluzione furono beffardi, perché si arrivò ad un compromesso che cinque anni prima si sarebbe potuto raggiungere senza spargimenti di sangue. Con il senno di poi sono tutti bravi – me compreso – ma non ci si può esimere da un tale commento dopo aver assistito ad una simile devastazione, l’entità della quale fece stropicciare gli occhi persino ai diretti interessati. Nelle sue memorie, Giovanni VI Cantacuzeno scrisse: “Dopo la morte del giovane Andronico, scoppiò la peggiore guerra civile che i romani abbiano mai conosciuto. Fu una guerra che portò alla quasi totale distruzione, riducendo il grande impero dei romani a un’ombra debole di quello che era stato”.
Tutti i torti il co-imperatore non li aveva. Le conseguenze per Bisanzio furono drammatiche. Le ingenti perdite territoriali resero l’impero un dominio fantoccio, insulso nelle dinamiche di potere regionali. Il tesoro si prosciugò in un lampo, nelle campagne prese il sopravvento l’anarchia, nessuno rispettò più il sistema tributario. Constantinopoli fu talmente impoverita dalla guerra civile che arrivò a dipendere dall’importazione del grano bulgaro e crimeano. Il collasso dell’amministrazione imperiale accentrata fece i conti anche con l’avvento della peste.

Di lì a poco sarebbe scoppiata una nuova guerra civile, ma il dado in un certo senso fu già tratto. Secondo un’altra autorevole bizantinista, Eva de Vries-Van der Velden, la guerra civile paleologa “marcò il punto di rottura tra declino e caduta dell’impero bizantino”. Come ben sapete (se avete seguito la miniserie sugli eredi spirituali di Costantinopoli), qualche macchia di fioritura economica e commerciale nel mondo bizantino sopravvisse. Ma questa è un’altra storia. Il concetto che è importante capire e dopo il quale mi taccio è il seguente: se l’autorità formale del basileus si conservò per un altro secolo, fu solo grazie ad un mix di fortuite coincidenze storiche e ad un’abilissima diplomazia estera.