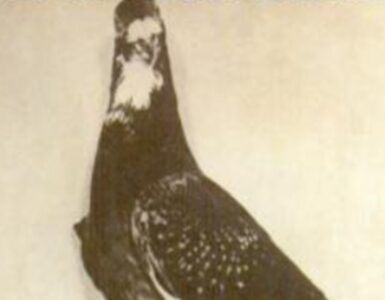Fotografia di Eric Valli, versante occidentale dell’Himalaya, Nepal, 1987. Gli scatti di Eric Valli, testimoni eccezionali di una pratica incredibile, riscossero un gran successo quando conobbero la pubblicazione. Scattate al tramonto del 1987, vinsero il World Press Photo Contest del 1988. Esse catturano un momento sospeso tra rischio, tradizione e spiritualità. L’uomo ritratto è Mani Lal, capo di un villaggio Gurung del Nepal centrale, intento a raccogliere il miele delle api giganti himalayane (Apis dorsata laboriosa), tra le più grandi del mondo. L’immagine è impressionante: il raccoglitore è appeso a una fragile scala di bambù che penzola nel vuoto, mentre attorno a lui sciami di insetti infuriati difendono i loro enormi favi incastonati sulle pareti scoscese delle montagne. Straordinaria amministrazione per uno dei pochi cacciatori del miele rimasti in Nepal .

La pratica della caccia al miele tra i Gurung affonda le sue radici in secoli di tradizione ed è legata non solo alla sussistenza, ma anche al rituale e al mito. I favi si trovano su dirupi verticali, spesso a oltre 3.000 metri di quota, in luoghi accessibili soltanto attraverso scalate pericolose.
Per raggiungerli, gli uomini del villaggio costruiscono lunghe scale di bambù, intrecciate con corde di fibre vegetali. Calandosi nel vuoto, affrontano sciami aggressivi e punture dolorose. Con bastoni di bambù muniti di lame o ganci, i cacciatori del miele staccano i favi e li raccolgono in grandi cesti intrecciati. Parte del miele finisce nei banchi del mercato di Kathmandu, e da lì raggiunge clienti da tutto il mondo (in grado di sostenere costi spaventosi…).

L’economia e il commercio c’entrano relativamente con quello che fanno i Gurung. La raccolta avviene due volte l’anno, in primavera e in autunno. Infatti l’opera segue un calendario che intreccia credenze religiose, astrologia e cicli naturali. Prima di iniziare, il capo del villaggio o lo sciamano (pani guru) compie rituali propiziatori. Offre sacrifici agli spiriti delle montagne e agli dei che proteggono la comunità. Si ritiene infatti che la foresta e le api appartengano a divinità e spiriti ancestrali, e che il miele sia un dono sacro, da prendere con rispetto.

Che il miele goda di questa considerazione non è affatto strano. Si tratta di un bene davvero speciale. Prendiamo ad esempio quello primaverile, prodotto dal nettare di rododendri. Questo contiene tracce di grayanotossina, una sostanza che in piccole dosi ha effetti allucinogeni e viene usata nella medicina tradizionale per curare disturbi come ipertensione, diabete o dolori articolari. È chiamato “miele pazzo” e viene venduto a caro prezzo, soprattutto sul mercato asiatico. Il miele raccolto in autunno, invece, è meno tossico e più adatto al consumo alimentare quotidiano.

Eric Valli, fotografo e documentarista francese, trascorse mesi con le comunità Gurung per documentare questa pratica che già allora stava scomparendo. La modernizzazione, la progressiva deforestazione e la diminuzione delle api giganti hanno reso la caccia al miele sempre più rara. Mani Lal, il protagonista della foto, era definito “l’ultimo del villaggio” ad averne appreso la tecnica, ereditata dal padre sciamano.
Oggi, questa tradizione sopravvive solo in poche comunità isolate, ed è diventata anche oggetto di interesse turistico e antropologico. Ma la fotografia di Valli resta una delle testimonianze più potenti. Non mostra soltanto un gesto estremo, ma racchiude il legame profondo tra uomo e natura.