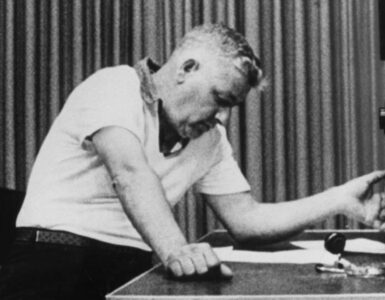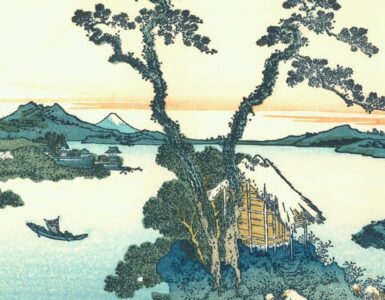Metti insieme degli archeologi, dei biologi molecolari e dei genetisti e cosa scoprono? Che la salsa segreta dell’Impero romano, quel garum dal sapore pungente e salmastro, era a base di sardine. Esatto, proprio così: le sardine europee, molto simili a quelle che ancora oggi nuotano al largo delle coste iberiche, erano il segreto più recondito dell’Impero romano.
L’Impero romano e quel debito culinario con le sardine

In un articolo pubblicato su Antiquity, gli scienziati hanno recuperato e sequenziato il DNA antico provenienti da una vasca romana usata per la salatura nel pesce. La vasca si trovava nel sito di Adro Vello, nella Spagna nord-occidentale.
Solitamente la fermentazione è un processo ostile dal punto di vista chimico e fisico per questo genere di esami. Fra macinatura, salatura e salamoia acida è spesso difficile recuperare del materiale genetico intatto. Eppure i ricercatori ce l’hanno fatta: hanno trovato del DNA utile da lische di pesce rotte sepolte fra i residui di produzione del garum.
La dottoressa Paula Campos del CIIMAR dell’Università di Porto, autrice principale dello studio, insieme al suo team è riuscita a identificare la specie di appartenenza di quelle lische. Si trattava della Sardina pilchardus, la comune sardina europea.

In realtà gli scienziati avevano già ipotizzato una cosa del genere, ma mancava la conferma genetica. Che adesso, invece, è arrivata. Considerate che il garum era importantissimo nella cultura culinaria dell’Impero Romano. In pratica era il ketchup, la salsa di soia e la salsa di ostriche dell’antico Mediterraneo, tutto in uno però.
Era onnipresente nelle cucine romane e i cuochi dell’epoca, sia amatoriali che professionisti, la usavano per insaporire di tutto, dai cereali alla carne, passando anche per le verdure. Pensate che in Hispania e nel Nord Africa c’erano delle cetariae, delle vere e proprie fabbriche di salatura del pesce, sparse su tutta la costa atlantica.

Il sito di Adro Vello, da dove è emerso il campione, è un esempio particolarmente ben conservato di queste fabbriche. Una ricostruzione 3D dello scavo ha ricreato uno stabilimento di lavorazione molto grande, capace di produrre il garum sia in forma liquida (garum vero e proprio), che in forma solida (allec).
Seneca, una volta, lo prese in giro definendolo come “le viscere costose di un pesce marcio”. Nonostante il cinismo delle sue parole, è indubbio che il garum fosse usato sia localmente che spedito all’estero. E in grandi quantità.
Lo studio ha poi avuto un risvolto inaspettato. Ha permesso di stabilire che la continuità genetica nelle sardine si è mantenuta stabile per più di 1.700 anni. In pratica le sardine antiche erano geneticamente sovrapponibili alle loro controparti contemporanee. E chissà quanti segreti ancora nasconderanno i resti di pesce andato a male ormai da secoli?