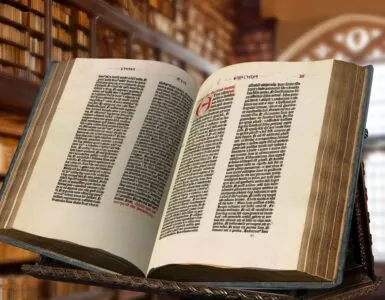Almanacco del 23 novembre, anno 1914: dopo setti mesi termina l’occupazione statunitense di Veracruz. Quest’ultimo si risolse in un intervento militare sintomatico della cosiddetta “diplomazia delle cannoniere” – con cui Washington cercava di imporre la propria influenza nell’area del Golfo del Messico (esatto, del Messico, in buona pace dell’amico Trump, n.d.r.) all’inizio del XX secolo.

È pressoché impossibile capire l’evento del 23 novembre ’14 senza dare un po’ di contesto storico, e per farlo dobbiamo tirare in ballo la Rivoluzione messicana, il coinvolgimento americano e il cosiddetto “caso Tampico“.
All’inizio dell’anno in Messico si frapponevano principalmente tre fazioni: le forze armate fedeli a Victoriano Huerta, generale che dal 1913 esercitava un potere autoritario e dittatoriale nel Paese; i rivoluzionari radicali (associabili a volti noti quali Pancho Villa o Emiliano Zapata); infine i costituzionalisti, sostenitori di un moderato liberalismo rispettoso dei dogmi costituzionali, che scelsero come leader Venustiano Carranza.
Al di là di dovute e necessarie semplificazioni, accadde che nell’aprile 1914 l’esercito messicano di Huerta arrestò nove marinai statunitensi nella località di Tampico. Fu un malinteso, ma bastò a sancire la rottura delle relazioni diplomatiche fra Messico e Stati Uniti d’America. Il presidente Woodrow Wilson utilizzò il pretesto del caso Tampico per spedire l’esercito a Veracruz, città portuale che domina il Golfo del Messico. Una rappresaglia iniziata il 21 aprile e terminata, come anticipato, il 23 novembre 1914.

Ciò che sappiamo grazie all’analisi a posteriori dei documenti di Stato, è che l’amministrazione Wilson aveva pianificato l’occupazione di Veracruz da mesi. Wilson, che si proclamava difensore dei principi democratici, aveva però anche obiettivi strategici: garantire la sicurezza dei giacimenti petroliferi del Golfo e impedire che potenze europee – qualcuno ha detto Germania? – potessero interferire negli affari messicani. Dunque, quando si seppe che la nave tedesca Ypiranga stava trasportando armi dirette a Huerta, colsero la palla al balzo.
Il 21 aprile 1914, senza dichiarazione di guerra, le navi dell’ammiraglio Frank Friday Fletcher aprirono il fuoco sul porto e sbarcarono i primi reparti di marines. Una resistenza da parte messicana si verificò, ma fu abbastanza inefficace. Dopo giorni di combattimenti casa per casa e colpi d’artiglieria sparati indiscriminatamente contro obiettivi militari e civili, il 27 aprile la bandiera a stelle e strisce fu issata sul palazzo del governo municipale.

Contrariamente alle aspettative di Wilson, la presa di Veracruz non provocò il crollo immediato del regime di Huerta. Anzi, generò un’ondata di indignazione nazionale in Messico. L’invasione suscitò un rarissimo momento di unità tra le fazioni rivoluzionarie e rafforzò lo spirito patriottico. Studenti, operai, contadini e religiosi si mobilitarono in difesa della sovranità nazionale.
Gli Stati Uniti, che avevano creduto di essere accolti come “liberatori”, si ritrovarono isolati diplomaticamente. Gli stati latinoamericani (in particolare Argentina, Brasile e Cile) si offrirono come mediatori nella crisi. Essi convocarono una conferenza di pace in Canada. Fu il primo grande tentativo sudamericano di risolvere una crisi interamericana senza la mediazione di Washington.

Nel frattempo, le truppe statunitensi restarono di stanza a Veracruz, amministrando direttamente la città in un clima di crescente ostilità. Le autorità locali messicane rifiutarono di collaborare, e gli occupanti dovettero occuparsi di tutto (scusate il gioco di parole). Per mesi la città visse in una tensione costante, con scontri sporadici, proteste e un’economia paralizzata.
Solo nel tardo autunno del 1914, con la caduta di Huerta e l’affermazione dei costituzionalisti di Venustiano Carranza, la situazione mutò. Wilson, che considerava Carranza un interlocutore più affidabile, ordinò la ritirata delle forze d’occupazione. Così, il 23 novembre 1914, dopo sette mesi e due giorni, le truppe statunitensi lasciarono Veracruz. Come è facile immaginare, la popolazione, cittadina come nazionale, accolse la notizia con enorme felicità.

Possiamo dire che per il Messico fu una vittoria morale. Un simbolo della resistenza nazionale contro l’imperialismo straniero. Per gli USA, invece, la vicenda si rivelò un boomerang diplomatico; lungi dal migliorare i rapporti con il vicino meridionale, l’intervento di Veracruz alimentò una profonda diffidenza antiamericana in tutta l’America Latina, minando la credibilità della politica “moralista” proclamata da Wilson. Non è un caso se di lì a qualche anno sarebbe scoppiato il caso del telegramma Zimmermann…