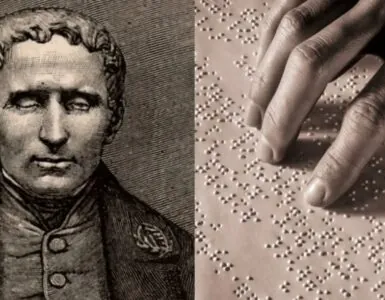Almanacco del 7 luglio, anno 1124: la città di Tiro, ultimo porto assieme ad Ascalona sotto il controllo musulmano, cade nelle mani dei crociati dopo un violento assedio. Il contesto è quello offerto dalle guerre veneto-bizantine (1122-1126), altresì impropriamente (vedremo perché) chiamate dalla storiografia anglosassone “crociate veneziane”. L’episodio del 7 luglio 1124 è cardinale nel quadro delle spedizioni militari cristiane in Oriente nel XII secolo, ma è anche un momento emblematico dell’ascesa della potenza marittima e commerciale della Repubblica di Venezia.

Togliamoci subito il dente. Ho definito “impropria” la definizione di crociata per il seguente motivo. L’impresa militare veneziana, pur essendo collocata all’interno della cronologia delle crociate, ha caratteristiche profondamente diverse. Anzitutto non fu promossa da un papa, né fu animata da motivazioni religiose (per quanto un certo tipo di storiografia affermi il contrario…). A far sì che la flotta veneziana prendesse il largo furono semmai obiettivi strategici e mercantili, posti in cima alla lista delle priorità da un governo dogale che già guardava a sé stesso come espressione politica di una potenza marittima indipendente.
Volendo, ci si può chiedere cosa fosse davvero Venezia in quel primo quarto di XII secolo. Senza approfondire troppo – vista la natura di questo articolo – si può dire come Venezia all’epoca fosse una spensierata repubblica, in piena espansione, contraddistinta da una forte vocazione commerciale e marittima. Il suo sistema di governo, fondato sulla coesistenza di un’oligarchia mercantile e di un’élite patrizia (progressivamente le due categorie finirono per combaciare), puntava a consolidare i traffici con il Levante, oltre che ad ottenere vantaggi esclusivi nei porti dell’Impero romano orientale e nei territori cristiani sorti in Terra Santa dopo la prima crociata (1096–1099).

A partire dal secondo decennio del XII secolo, la Serenissima aveva iniziato a concepire il fenomeno crociato come un’occasione per affermare la propria influenza sui principali scali del Mediterraneo. Insomma, dalle parti di San Marco si pensò bene di unire il fervore religioso a un preciso calcolo politico-economico. Non che fossero gli unici a farlo, s’intende. In un siffatto contesto maturò l’idea della spedizione del 1122.
In realtà il doge Domenico Michiel, in carica dal 1116, intervenne in Levante mosso da un duplice obiettivo. Rispose affermativamente alla richiesta d’aiuto lanciata da Baldovino II, re di Gerusalemme finito in cattività presso i musulmani. Ma questo era il “motivo di facciata”. Sì, perché la vera ambizione di Venezia si esplicava nel tentativo, neppure troppo velato, di rispondere col muso duro alle manovre politiche e commerciali di Costantinopoli.
Con la sua imponente flotta – all’incirca 70 imbarcazioni fra galee, rostrate e navi onerarie – la Serenissima volle portare guerra al basileus Giovanni II Comneno. Sia perché quest’ultimo non aveva rinnovato, come richiesto da Venezia, la crisobolla del 1082. Sulla base di quell’editto si fondava il privilegio economico della repubblica lagunare, ex ducato bizantino. Sia perché gli agenti commerciali di Costantinopoli s’impegnarono in quegli anni a disturbare, se non addirittura intralciare, gli affari mercantili veneziani nel Mediterraneo orientale.

Se poi al salvataggio del re di Gerusalemme si sarebbero corrisposti ingenti vantaggi di carattere amministrativo, politico e commerciale da applicare a tutti i porti cristiani levantini, allora comprendiamo ancor meglio l’agire veneziano. Diciamo che gli elementi per un massiccio intervento armato in Levante c’erano tutti.
La flotta veneziana salpò nel 1122 e nel corso del viaggio non esitò a compiere incursioni nei territori dell’Impero bizantino. Dopo aver messo a ferro e fuoco diverse località egee, la flotta veneta puntò dritto su Tiro. La città difesa da imponenti mura era l’ultimo baluardo, assieme ad Ascalona, in mano alla multipolare forza musulmana. Dietro le sue mura si asserragliarono soldati fedeli al Califfato Fatimide d’Egitto e supportati direttamente dall’Emirato di Damasco. Le fonti non riportano gli effettivi musulmani. Ma sappiamo come essi resistettero all’assedio “franco” (veneziani sommati alle truppe inviate dalla Contea di Tripoli) per ben cinque mesi.
Da febbraio a luglio andò in scena un monologo veneziano: si bloccarono i rifornimenti via mare; i genieri realizzarono macchine da assedio, torri mobili e ponti flottanti; i soldati assalirono continuamente le mura cittadine. Mix di fattori che condussero gli assediati ad alzare bandiera bianca il 7 luglio 1124. Tiro diveniva cristiana. Secondo gli accordi, la popolazione musulmana abbandonò incolume la città. La capitolazione di Tiro fu un trionfo militare e simbolico per gli europei… Ancor più per Venezia, la quale ottenne condizioni estremamente favorevoli nel regno gerosolimitano.

Quando Baldovino II conobbe finalmente la libertà, concesse quanto promesso a Venezia. Ovvero decretò una “curia” autonoma all’interno della città, un quartiere commerciale indipendente dotato di propri magazzini, chiese e fondachi, oltre al diritto di battere moneta e riscuotere dazi. Era, in sostanza, una colonia veneziana in miniatura, sul modello di quanto già avveniva nelle città bizantine. Non finiva mica qui. Venezia ricevette un terzo dei proventi fiscali della città. I mercanti lagunari furono esentati da ogni tributo o tassa doganale e il potere giudiziario nella colonia divenne in parte autonomo rispetto all’autorità crociata locale.