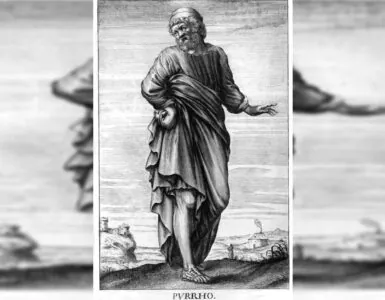Si scherza amici dei Paesi Bassi. O forse no? Al di là delle battute, quest’oggi voglio raccontarvi una storia che, come spesso sta capitando ultimamente, lega l’ambito alimentare a quello storico-sociale. Oggi si parla di carote viola, ma anche di una zelante operazione portata avanti dagli agricoltori olandesi del XVII secolo. La stessa iniziativa per la quale dobbiamo “ringraziarli” se nel mondo la carota è associata al colore arancione. Sì, perché c’era un tempo in cui le cose non stavano esattamente così…

Sua eminenza la carota, formalmente Daucus carota, è una pianta erbacea. Dal fusto verde e dalle radici di colore variabile, la carota appartiene alla famiglia delle Apiacee. La si conosce sin dall’antichità più remota (tanto che il suo nome deriva dal greco antico καρωτόν, karōton) ed è diffusa in quasi tutti i continenti del mondo. Biologicamente domesticata in Afghanistan nel III millennio a.C., da dove poi prese a diffondersi in Asia, Europa e Nord Africa.

Terminate le dovute presentazioni, passiamo al punto focale della questione, il colore dell’ortaggio. Benché le carote siano sempre esistite in diverse varietà cromatiche, le testimonianze storiche indicano che in Afghanistan venivano coltivate prevalentemente quelle di colore viola e giallo. Cultivar (in agronomia “insieme di piante coltivate specificamente selezionate”) che il mondo occidentale conobbe grazie ai musulmani in al-Andalus nell’VIII secolo. Anche se dalle parti di Costantinopoli ne avevano coscienza già da duecento anni.
Se fino alla fine del Cinquecento aveste chiesto ad un contadino qualunque di che colore fosse la carota, egli con molta probabilità vi avrebbe risposto “viola”. Com’è che oggi sono arancioni e anzi, le carote viola sono sinonimo di “esotico”, al pari, chessò, di mango, quinoa e carambola? Tutta colpa degli agricoltori olandesi, almeno così dice una buona parte degli studiosi.

Secondo quest’ultimi, i contadini nederlandesi ibridarono la cultivar “Long Orange” in onore dello statolder Guglielmo d’Orange e soprattutto con lo scopo di replicare il colore primario della Prinsenvlag, la Bandiera del Principe, arancione, bianca e blu. Il vessillo fu adottato per la prima volta dai ribelli olandesi nel XVI secolo, insomma, agli esordi della lunga Guerra degli Ottant’anni. A forza di mescolare le diverse varietà, gli agricoltori delle Province Unite riuscirono a tirarne fuori una completamente arancione.

Tuttavia questa è solo una delle due campane. Ci sono studi che motivano il prevalere del colore arancione su quello viola su basi estetiche. Essi sostengono che nelle cucine europee d’età moderna, i cuochi preferissero ricorrere alla carota arancione invece di quella viola cosicché le zuppe apparissero più attraenti ed invitanti. Il viola in effetti anneriva i piatti e dava meno risalto al prodotto finale.

Le semenze afghane, se vi interessa saperlo, malgrado si vedano poco in giro, non sono mica estinte. Nel nostro continente, così come altrove, si continua a coltivarle perché ricche di antiossidanti. In Italia è la regione Puglia ad imporsi per la produzione di carote viola, con le colture di Polignano a Mare (Bari) e di Tiggiano (Lecce). Se gradite queste curiosità storico-alimentari, non fatevi sfuggire gli approfondimenti sulle ostriche o sull’ineguagliabile cipolla!