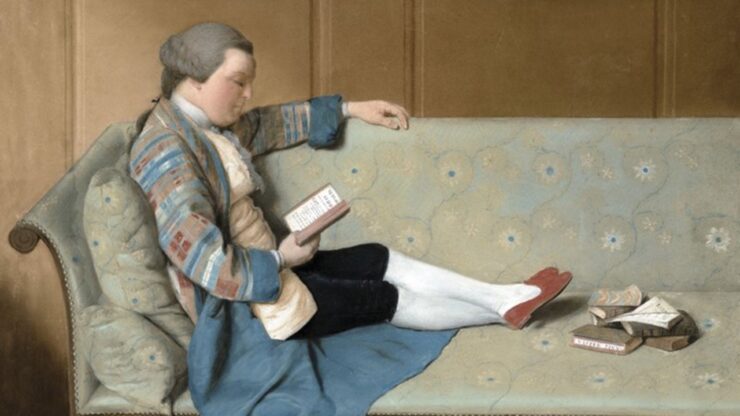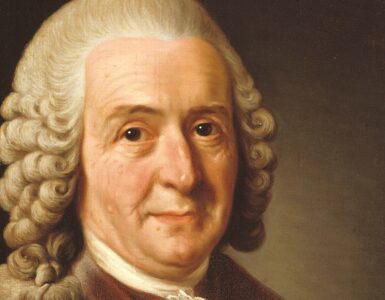“Libri, libri ovunque. E questi giovani di oggi? Che sfogliano pagine, si concentrano, leggono… Non fanno altro che leggere tutto il giorno! Dove andremo a finire signora mia?!” – Me le immagino così le conversazioni tra affrante madri vissute nel pieno del XVIII secolo, epoca in cui i romanzi andavano sempre più di moda e una certa società, preoccupata com’era a preservare l’oscurantismo dei giorni migliori, lanciava l’allarme sulla tendenza giovanile a trascorrere le giornate a leggere. Il mondo alla rovescia.

Ragazzi che leggono e che dunque sprecano tempo. Questa era la massima che andava per la maggiore nell’Europa del Settecento. Sembra buffo o curioso pensarlo, almeno con l’ottica del XXI secolo, ma ci fu un tempo in cui la lettura era considerata sconclusionata, frivola, se non addirittura pericolosa. Qualcuno coniò persino termini allarmistici come “mania della lettura” o “febbre della lettura“.
Un caso esemplare è ravvisabile nell’area germanofona della seconda metà del XVIII secolo, dove la crescita esponenziale del mercato librario, dell’editoria e di conseguenza della platea di lettori, la quale coinvolgeva ora le classi meno abbienti, fece scattare a qualcuno un campanello d’allarme. La chiamarono epidemia: Lesesucht, ovvero dipendenza da lettura, o Lesewut, mania della lettura. Eccessi che corrompevano il cervello dei giovani, ma anche delle dame, dei popolani e dei borghesi.
Sono sopravvissuti al tempo documenti sensazionalistici in cui si condanna la diffusione capillare dei libri, ritenuti essere una delle principali – se non la principale – minaccia all’ordine morale e sociale costituito. In un certo senso mi permetto di “dare ragione” a questi allarmismi, poiché le grandi rivoluzioni del XVIII secolo traevano origine da ideali coltivati nella letteratura, nella filosofia e nel pensiero critico (oltre alle classiche motivazioni economiche e geopolitiche).

Non solo e non soltanto. Ciò che i detrattori condannavano era il fatto che chi leggeva fosse alla costante ricerca di nuove sensazioni, quasi si trattasse di una patologia. Gli storici, in accordo con esperti psicologi comportamentali, ci aiutano a comprendere il perché di tutto ciò. Matt Erlin, professore di letteratura alla Washington University, sostiene come le paranoie relative “ai giovani che leggono” si possono concepire nell’ambito di una società dove l’elemento commerciale era sempre più prioritario. Anche per questo leggere venne inquadrato più come un consumo invece di un passatempo ricreativo.
Un po’ come accadeva per il caffè, da alcuni predicatori considerato un pericoloso stimolante e la porta d’accesso allo snervamento sociale, si temeva che l’eccesso di lettura comportasse auto-indulgenza e tranquillità, dalle quali originava una problematica riluttanza al lavoro e alla sopportazione fisica.
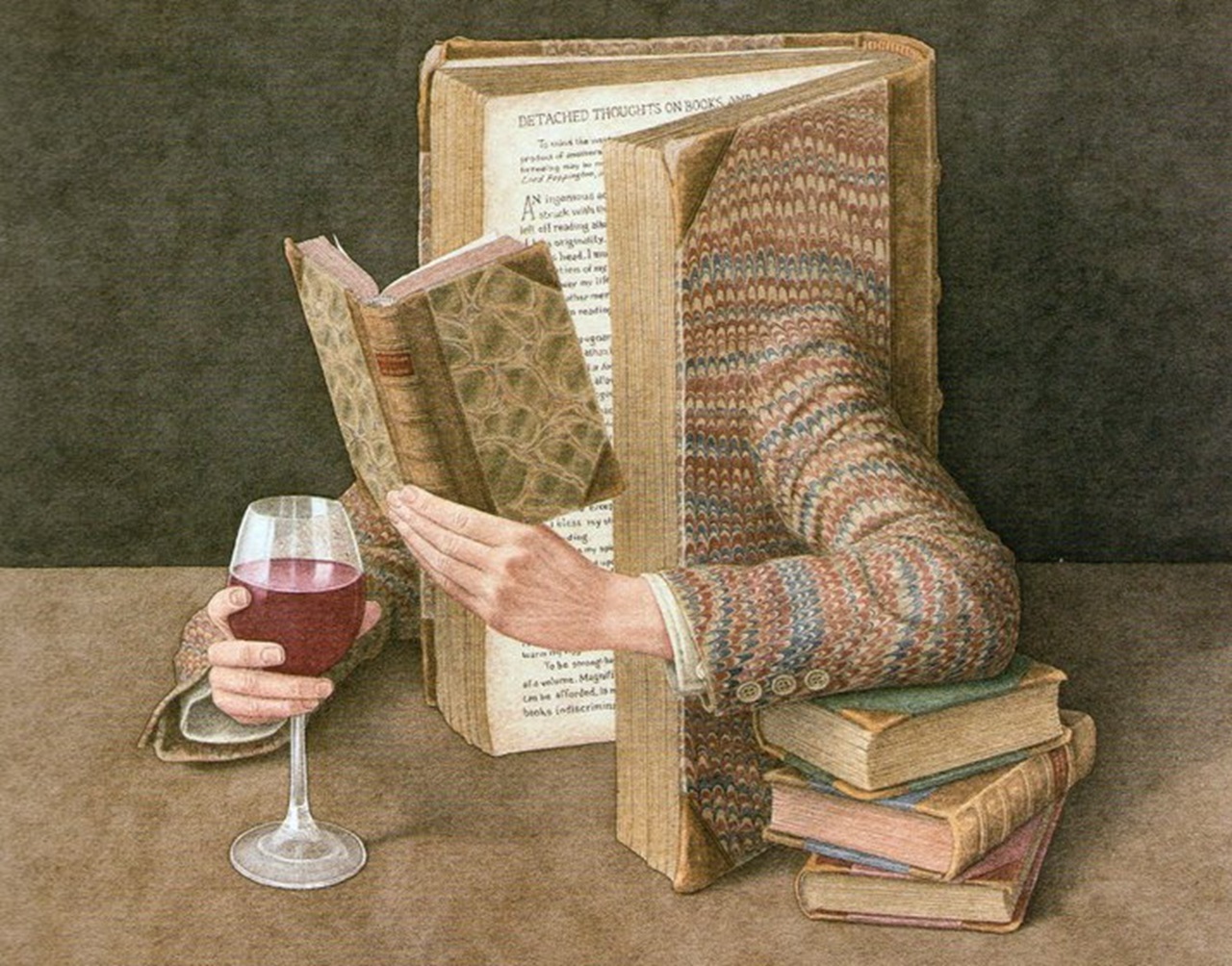
L’Inghilterra d’epoca vittoriana scagionò la lettura da questa retorica fatalista. A Londra si assisté ad una progressiva “democratizzazione” della stessa. Era consuetudine per alcuni prendere parola in pubblico, tenendo fra le mani un libro, e leggere alcuni passi. Accadeva nei pub, nelle biblioteche, nelle stazioni dei treni, per strada. È ovvio, oltre che risaputo, che semplificare l’accesso al sapere rende problematica la gestione del potere. Il cambiamento poi provoca sempre ansie e timori d’ogni sorta. Unite i due fattori e il risultato… Beh, già lo sapete.