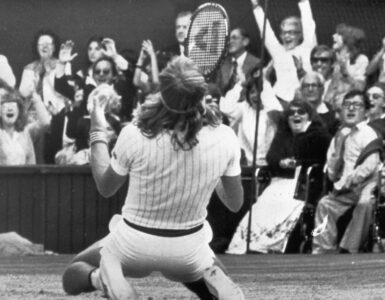Fotografia di Frank Carpenter, Medio Oriente, probabilmente Levante, 1900-1910 circa. Una donna beduina, forse originaria del deserto siro-palestinese, posa per uno scatto fotografico. Un discorso storico-culturale sul soggetto, sul contesto in cui venne scattata la foto e sull’autore della medesima può scaturire una serie di riflessioni affatto banali; non vedo perché esimerci…

Si parta proprio dall’ultimo dei tre elementi elencati, l’autore. Frank George Carpenter fu un gigante della fotografia di viaggio operante a cavallo fra Otto e Novecento. Chi è un minimo appassionato di geografia storica, conosce benissimo il suo nome come è perfettamente consapevole del peso delle sue opere.
Queste non erano destinate solamente al gusto estetico, ma avevano una forte vocazione didattico-geografica. Con l’aiuto della figlia Frances, Carpenter viaggiò intensamente e produsse immagini per illustrare i suoi libri scolastici e le sue guide di viaggio. La Libreria del Congresso statunitense conserva oggi la vastissima collezione Carpenter, considerata una delle testimonianze visive più preziose sulla vita quotidiana nei paesi extra-europei all’inizio del Novecento. Un domani tornerò a parlarvi del vecchio Carpenter, ma ora torniamo sulla fotografia.
A livello artistico, lo scatto è rigorosamente composto. La donna che vediamo essere in posa, con lo sguardo rivolto fuori campo verso sinistra, è in una postura che vuole comunicare prima di tutto dignità, oltre ad una certa fierezza (parere personale). Il vestiario è fluente, stratificato, contraddistinto da tessuti pesanti e decorati. Carpenter, pur agendo secondo uno scopo documentaristico, costruisce l’immagine con profonda consapevolezza scenica. Non a caso è considerato all’unanimità come uno dei mostri sacri della fotografia tardo ottocentesca e primo novecentesca.

Della donna beduina del deserto siro-palestinese non abbiamo notizie biografiche. Ma non per questo ci tiriamo indietro da un’analisi sociale e storica entro la quale trova spazio lo scatto. Esso offre una finestra su una società che stava rapidamente cambiando, nel contesto del tramonto dell’Impero ottomano e della crescente presenza occidentale nel Vicino Oriente.
Si potrebbe tranquillamente parlare di “orientalismo“, in riferimento alla teoria avanzata per la prima volta da Edward Said, per la quale – detta in soldoni – l’Occidente ha studiato l’Oriente solo in funzione di un’autolegittimazione al potere, in quanto soggetto maggiormente avanzato e progredito, tale da giustificare il “possesso” dell’Oriente, povero e tradizionalista. Ma non credo che la fotografia ci permetta di spaziare così tanto.
Più idoneo al contesto sarebbe un discorso sull’identità dei beduini all’inizio del XX secolo. Essi costituivano all’epoca una componente sociale importante nelle regioni desertiche e semi-desertiche del Levante. Nomadi o semi-nomadi, legati a rigide strutture tribali, vivevano di pastorizia e commerci. Le donne svolgevano un ruolo rilevante, non solo domestico ma anche economico e talvolta sociale. Il ritratto di Carpenter va oltre l’estetica, come già detto e ripetuto, perché racconta un sistema di vita che stava cominciando a entrare in crisi sotto la pressione della sedentarizzazione forzata, delle riforme ottomane (le celebri Tanzimat) e, successivamente, delle amministrazioni coloniali inglesi e francesi dopo il 1918.

È la fotografia di una donna, ma anche di un mondo in transizione, sempre a voler ricordare il contesto storico. Gli elementi visivi che ci parlano di un’identità salda li abbiamo individuati, eppure non dobbiamo dimenticare contro cosa quell’identità andò a sbattere. Andò ad infrangersi contro una modernità imposta con la guerra, quando non con la politica colonialista e con giochi di poteri più grandi di qualunque tribù nomade dell’area mediorientale. Carpenter ritrasse una donna che, molto probabilmente, fu figlia dell’ultima generazione ad aver vissuto pienamente un’esistenza beduina nel deserto prima dell’arrivo dei censimenti, delle carte d’identità, dei confini, degli stati-nazione.