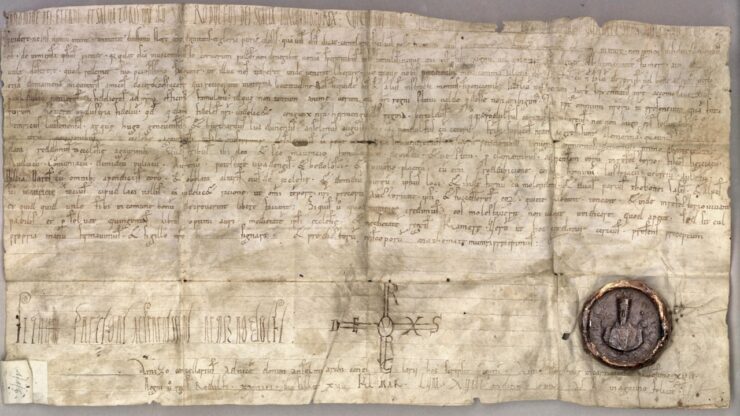Almanacco del 6 settembre, anno 1032: con la morte di Rodolfo III d’Arles, ultimo membro della dinastia dei Rudolfingi, si innesca la crisi di successione borgognona. Si tratta di un episodio storico che, per chi non si occupa di storia medievale, appare come circoscritto e marginale. Invece ebbe un peso enorme sugli equilibri dinastici e geopolitici dell’Europa post anno mille. Cercheremo di capire perché, affrontando la vicenda dal suo momento iniziale, ovvero il 6 settembre 1032.
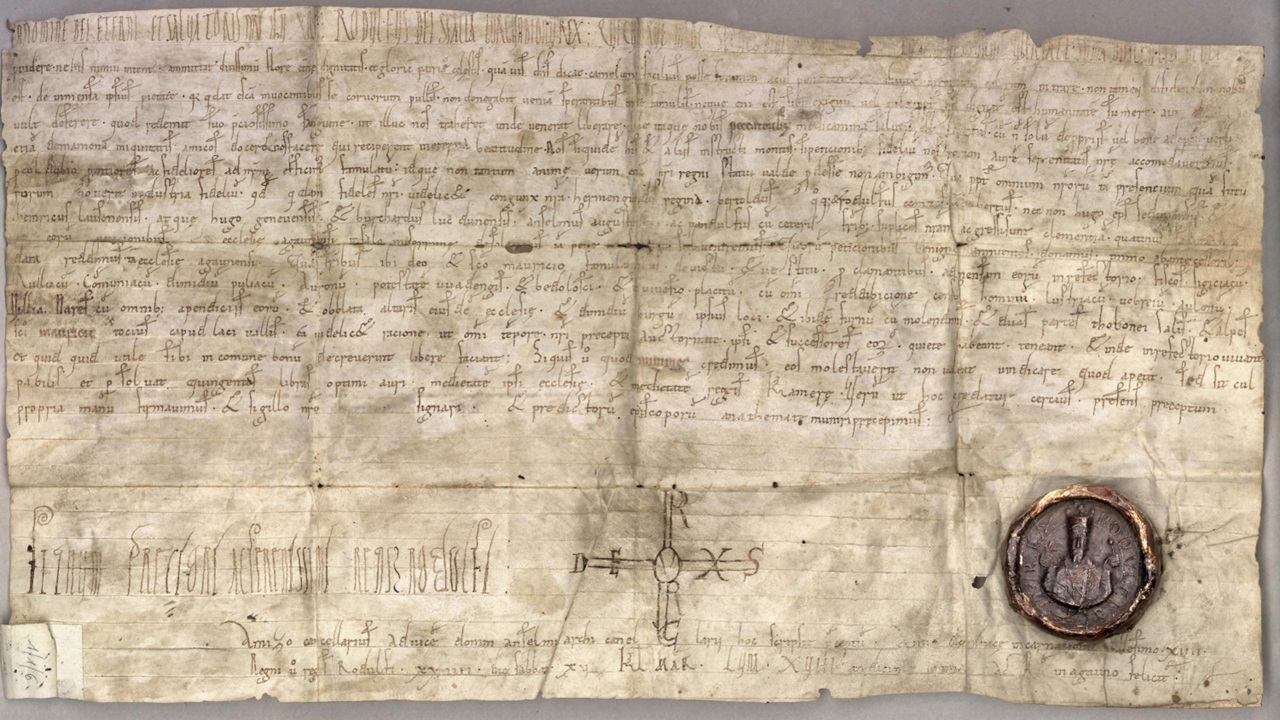
Dunque, iniziamo proprio da questa data importante per la storia dell’Europa centro-occidentale. Il 6 settembre 1032 esala il suo ultimo respiro Rodolfo III, ultimo della dinastia dei vecchi Guelfi. Il Casato reggeva da oltre un secolo il cosiddetto “Regno di Arles” o “di Borgogna”. Questo regno, nato nel 933, occupava un’area chiave: il corridoio alpino occidentale tra il Rodano, le Alpi e il Giura, corrispondente grosso modo alla Svizzera occidentale, alla Savoia, alla Franca Contea e alla Provenza settentrionale.
Sapete perché il Regno di Borgogna era così fondamentale per l’equilibrio di potere dell’Europa della prima metà del XI secolo? Basta osservare una mappa politica del tempo e puntare l’indice sui domini borgognoni. Essi si trovano in un punto oltremodo strategico, in mezzo a tutto, con il Regno di Francia a ovest, il Sacro Romano Impero ad est e i territori formalmente sotto l’egida della Corona d’Italia a sud.
Con la morte di Rodolfo, senza figli legittimi, si aprì la questione della successione. O meglio, si aprì la crisi di successione borgognona. Rodolfo, in più riprese, aveva designato come erede Enrico III, il giovane figlio dell’imperatore Corrado II il Salico. Ma la scelta non era pacifica, perché esistevano altri pretendenti con legami dinastici più diretti. In particolare Oddone II di Blois, nipote di Rodolfo tramite sua madre, che vantava un diritto più immediato sul piano genealogico.

La guerra che seguì tra Corrado il Salico e Oddone II non fu solo una disputa familiare, ma rifletteva due concezioni diverse della legittimità dinastica. Oddone si appoggiava al diritto di sangue; era il nipote diretto di Rodolfo III e dunque, in teoria, erede più prossimo. A sostenerlo erano potenti signori borgognoni, prelati e conti locali che vedevano in lui la garanzia di un regno autonomo, legato più alla Francia che all’impero.
Corrado, invece, difendeva il diritto testamentario e politico. Rodolfo aveva scelto come erede il suo pronipote Enrico III, e l’impero poteva presentarsi come garante della continuità e della stabilità. A suo favore giocava anche la capacità di mobilitare le risorse militari e diplomatiche dello stesso.
La guerra fu senz’altro dura, contraddistinta da assedi, campagne invernali disastrose (celebre l’inverno del 1033, quando – raccontano le cronache – gli zoccoli dei cavalli gelavano al contatto col terreno e bisognava spaccare il ghiaccio con le asce per liberarli), alleanze incrociate e devastazioni, in particolare in Champagne e Lorena. Alla fine, dopo la sottomissione di Oddone (1033) e la caduta degli ultimi castelli ribelli (1034), Corrado poté farsi riconoscere come re di Borgogna insieme al figlio Enrico.

Ed è qua che voglio focalizzare la vostra attenzione. La vittoria di Corrado (e indirettamente di Enrico) significò l’ingresso della corona di Borgogna nella galassia imperiale. Una svolta geopolitica radicale per l’Europa del tempo. Anzitutto, bisogna sottolineare il valore simbolico della questione. Corrado racchiudeva nella sua persona le storiche tre corone del Rex Romanorum (il Re dei Romani): quella di Germania (pardon, dei Franchi orientali), d’Italia e di Borgogna.
Ma più importante, almeno su un piano pratico e letteralmente geopolitico, era il controllo che il Sacro Romano Impero si era garantito sui passaggi alpini occidentali. Un controllo che da una parte rafforzava gli imperatori e che dall’altra marginalizzava il Regno capetingio di Francia. Parigi vide sfumare la possibilità di inglobare la Borgogna imperiale (da non confondere con il Ducato di Borgogna, che resterà sotto influenza francese). Questo segnò una prima, netta delimitazione tra sfera capetingia e sfera imperiale, destinata a ripetersi nei secoli.
Piccola chicca finale. La crisi borgognona del 6 settembre 1032 ci riguarda da “vicino”. Il consolidamento imperiale premiò famiglie fedeli come quella di Umberto Biancamano di Savoia, che ottenne la Moriana e l’Aosta, ponendo le basi della futura dinastia sabauda. Da qui si sviluppò il primo nucleo della contea di Savoia.