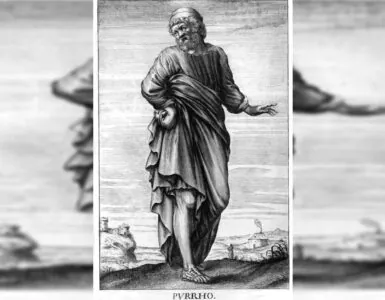In occasione della parata del 2 giugno, davanti i miei occhi sono passati loro, gli uomini in divisa del 1º Reggimento “Granatieri di Sardegna”. Impossibile non riconoscerli, in particolar modo per i berrettoni neri che indossano e che li fanno sembrare alti due metri e mezzo. Dopo averci rimuginato un po’, ho individuato delle similitudini fra i nostri Granatieri di Sardegna e le guardie inglesi del re, avete presente no? Quelli famosi per non muovere neppure un ciglio, cascasse il mondo. Ecco, dopo aver collegato le due forze militari, è sorta spontanea la domanda: ma perché indossano lo stesso singolare copricapo? Qual è la sua origine? La risposta l’ho trovata, e voglio condividerla con voi.

Prima però chiediamoci: che cos’è un berrettone? Esso è anche noto col termine inglese Bearskin, letteralmente “pelle d’orso“. Si tratta di un copricapo di pelliccia, un alto colbacco dotato di pennacchio, cinghia da stringere sotto il mento, che si può decorare a seconda dell’evenienza. Oggi è in uso nella maggior parte dei corpi di guardia del mondo, ma non è sempre stato così.
Su dei berrettoni ante litteram si hanno notizie risalenti al XVII secolo. Tuttavia questi copricapi erano realizzati in stoffa, non ancora in pelliccia d’orso. I berrettoni in pelle d’orso sembrano esser spuntati fuori negli eserciti francesi, inglesi e spagnoli nella seconda metà del XVIII secolo. Non v’è certezza a riguardo, ma è probabile che i primi a indossarli siano stati i prussiani, subito imitati dalla controparte francese durante la guerra dei sette anni (1756-1763).

Perché cingersi il capo con quell’accessorio così ingombrante e apparentemente bislacco? Per sembrare più grandi e intimidire così il nemico, è ovvio. La diffusione massima però si ebbe a cavallo tra Sette e Ottocento, durante l’epoca d’oro di Napoleone. Inquadrati nella Grande Armée erano i fanti d’élite della Guardia imperiale. Solitamente – ma non sempre – essi venivano schierati a scontro in corso per sferrare il colpo di grazia alle fila nemiche. Perciò nelle ultime fasi della battaglia, i malcapitati di turno vedevano arrivarsi incontro questi omoni col berrettone che, moschetto alla mano, sembravano poter sgretolare una montagna, figuriamoci una colonna di uomini affaticati.

Accadde la stessa cosa a Waterloo, il 18 giugno 1815. Gli uomini della Guardia imperiale parteciparono alla storica battaglia ma non poterono mutare il corso degli eventi: come tutti sappiamo, la spuntò il Duca di Wellington. Quest’ultimo ordinò ai Grenadier Guards inglesi di prendere i berrettoni in pelle d’orso dai soldati francesi caduti in battaglia, come una sorta di trofeo. Da quel momento in poi, il berretto di pelle d’orso fu introdotto nella cultura militare inglese.
Lungo tutto il XIX secolo si comprese quanto fosse esosa la spesa per la produzione dei Bearskin e il mantenimento degli stessi. Se ne limitò la circolazione, riservandola a specifici corpi, per lo più cerimoniali. Rappresentarono un’eccezione i Royal Scots Greys (dragoni grigi scozzesi) che, berrettone sul capo, diedero vita ad alcune delle cariche più famigerate della storia durante la guerra di Crimea (1853-1856).

Giunti alle porte del secolo decimonono, nessun corpo armato operativo del mondo si avvalse dei tradizionali copricapi in pelle d’orso. Essi rimasero una prerogativa per le guardie di palazzo britanniche, belghe, danesi, olandesi, imperiali tedesche, russo e svedesi. E i Granatieri di Sardegna, con i quali ho introdotto l’argomento? Beh, il reggimento dismise subito il cappello, già nei primi dell’Ottocento; nel XX secolo lo hanno riabilitato per usi cerimoniali, leggasi parata del 2 giugno!