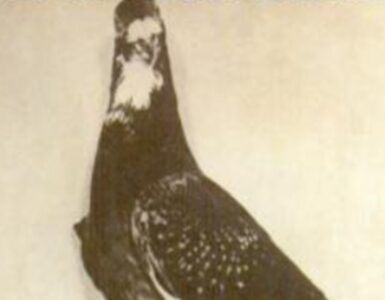Fotografia di anonimo, rotta di Malcantone, comune di Occhiobello (RO), Italia, novembre 1951. Lo scatto in bianco e nero mostra tutta la violenza distruttiva della natura con una quantità di acqua simile ad un mare che si abbatte su uno dei comuni di Rovigo. Sullo sfondo la case sembrano immerse in un oceano, in primo piano nulla, solo la potenza distruttiva di una delle alluvioni più catastrofiche della storia italiana.

Tra l’Adige e il Po c’è una vasta pianura in provincia di Rovigo, il Polesine. Qui, nel 1951, le piogge torrenziali continuate per giorni e giorni, misero a dura prova i limiti di resistenza della natura. Era un novembre piovoso e cupo, e, il giorno 14, l’argine del fiume Po non resistette più. Si era nei pressi di Occhiobello e, come visibile nella foto di apertura, la campagna non si distingueva più dal mare.
Quella di Occhiobello fu, purtroppo, solo una delle tre rotte degli argini del Po. Altra condizione che favorì il perpetrarsi della tragedia fu la quasi simultaneità delle esondazioni. Le rotte avvennero a distanza di pochi minuti, secondo le cronologie più accreditate: alle 19:15 a Vallone di Paviole (comune di Canaro), alle 20:00 in località Bosco (comune di Occhiobello) e, infine, alle 20:15, in località Malcantone (sempre Occhiobello).

Ma quando le cose iniziarono ad andare male, purtroppo, si aggiunsero altri fattori che le peggiorarono. In particolare ci furono due ostacoli, la Fossa di Polesella e il Canale di Valle. I due argini naturali, facendo da scudo al flusso naturale delle acque esondate, secondo recenti calcoli, aumentarono la percentuale dell’inondazione del 40%.
Alla fine ben 100.000 ettari di territorio subirono l’inondazione costringendo circa 180.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Il conto delle vittime è poi altrettanto spaventoso: 101 morti e 7 dispersi in quei tre tragici giorni. Erano passati pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, troppi pochi anni, e già l’Italia faceva i conti con una nuova disgrazia. La vicenda mise in luce la necessità del controllo idrico del territorio e della messa in sicurezza del corso del Po. Il principale fiume italiano risultava e risulta potentissimo e potenzialmente distruttivo per diverse regioni della Penisola.

Quella del Polesine fu una delle prime ferite che mostrò tutta la debolezza idrogeologica italiana. Da quel 1951 altri disastri si sono susseguiti nella nostra Penisola, ma almeno, progressivamente, si cercò di adeguare quanto più possibile le strutture esistenti e di costruire in maniera idonea quelle nuove. Confidando che, sempre partendo dal rispetto per la natura, si possa arrivare un giorno a ridurre al minimo, se non ad evitare totalmente, accadimenti del genere.