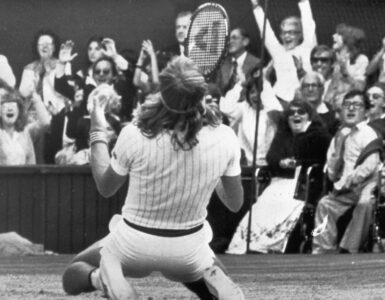Fotografia di Hengameh Golestan, Teheran, Iran, 8 marzo 1979. Oltre 100.000 donne sfilano per le strade della capitale gridando un secco “No” all’imposizione del velo ordinato dal regime khomeinista appena instauratosi. Ad immortalare l’evento storico, oltre che emblematico di un Iran in profonda trasformazione, ci fu Hengameh Golesta, pioniera della fotografia femminile iraniana. È grazie al suo coraggiosissimo lavoro, assieme a quello di poche altre, se oggi disponiamo di scatti documentaristici di ciò che accadde l’8 marzo 1979 a Teheran.

Esatto, ma cosa accadde? Nel febbraio del 1979 l’Iran era un paese in pieno mutamento. Dopo decenni di monarchia autoritaria sotto lo shah Mohammad Reza Pahlavi, la rivoluzione islamica aveva travolto ogni istituzione consolidata, sostituendo la vecchia élite con il potere carismatico e religioso dell’ayatollah Khomeini. Quelli erano sia giorni di esaltazione collettiva – per una maggioranza della nazione – e, allo stesso tempo, di crescente incertezza – per un corposa minoranza. Molti iraniani credevano che la caduta dello shah avrebbe aperto un’epoca di libertà, comportato giustizia sociale e modernità politica, seppure in forme islamiche. Ma ben presto divenne chiaro che il nuovo regime intendeva plasmare la società su un modello assai più rigoroso e tradizionalista.
Tra i simboli su cui si accese subito il conflitto ci fu il velo. Prima della rivoluzione, nelle grandi città come Teheran o Shiraz, una parte delle donne lavorava, frequentava l’università e sceglieva liberamente come vestirsi. Non era raro, soprattutto negli ambienti urbani e borghesi, vedere donne in tailleur, con i capelli scoperti e il trucco “all’occidentale“. La propaganda dello shah aveva enfatizzato questa immagine di emancipazione femminile come segno del progresso iraniano. Ma nella cultura popolare e nei quartieri più religiosi, la percezione era diversa: il velo continuava a essere un riferimento identitario importante.

Il 7 marzo 1979, appena un mese dopo il ritorno di Khomeini dall’esilio di Parigi, arrivò la prima ordinanza che obbligava le donne che lavoravano negli uffici pubblici a coprirsi il capo. Non era ancora una legge universale, ma fu un annuncio che colse tutti di sorpresa. Molte donne, soprattutto insegnanti, impiegate, funzionarie, giornaliste, si sentirono umiliate.
Il giorno seguente, l’8 marzo, si celebrava la Giornata internazionale della donna. Si diffusero voci di una manifestazione spontanea di protesta. Nessuno sapeva davvero quanti avrebbero osato scendere in strada. Dopo settimane di trionfalismo rivoluzionario e di consolidamento del potere religioso, era un atto rischioso. Eppure, in poche ore, una marea umana si radunò lungo il viale Taleghani. Erano donne di ogni età, per lo più vestite con soprabiti scuri, qualche sciarpa leggera sulle spalle, i capelli raccolti o sciolti, con capo e volto scoperti.

Hengameh Golestan, all’epoca una giovane fotografa professionista, si trovò lì con la sua macchina fotografica. In un’intervista molti anni dopo, raccontò che non aveva mai visto Teheran affollarsi così di donne decise a farsi sentire. Ricorda la determinazione e, allo stesso tempo, la vulnerabilità di quelle figure che avanzavano in massa, consapevoli che quella manifestazione sarebbe stata una sfida diretta alla teocrazia. La fotografia che scattò – e che oggi si ritrova su copertine di libri e mostre di storia contemporanea – cattura un momento di sospensione: un gruppo di donne che cammina, alcune con il pugno alzato, altre con espressioni tese, mentre intorno il corteo si allunga come un fiume.
Durante quella giornata, la tensione salì. I guardiani della rivoluzione, i ben noti Pasdaran, iniziarono a circondare le manifestanti, a gridare insulti e slogan di condanna. L’atmosfera si fece più cupa. Ma la protesta non si sciolse subito. Per giorni e giorni, piccoli gruppi di donne continuarono a riunirsi davanti ai ministeri, nei cortili delle università, nelle strade del centro. Orgoglio e resistenza civile, come mai prima di allora.
L’effetto mediatico fu enorme. La stampa internazionale, accorsa in Iran per documentare la rivoluzione, scoprì che uno dei primi atti del nuovo potere teocratico era colpire proprio le donne. Le fotografie fecero il giro del mondo e contribuirono a creare un’immagine contrastante del nuovo regime. Se da un lato persisteva la promessa di riscatto del popolo iraniano, dall’altro si stagliava l’ombra di un controllo oppressivo.

Purtroppo, quell’ondata di protesta non fermò il progetto politico di Khomeini. Nel giro di un anno, l’obbligo del velo fu esteso gradualmente a tutti gli spazi pubblici. Poi arrivarono altre restrizioni: il divieto di diventare giudici, la segregazione dei luoghi pubblici, le limitazioni nell’istruzione e nel lavoro. Quella prima resistenza divenne un ricordo amaro per molte di quelle donne che, fino all’ultimo, avevano sperato in una rivoluzione che potesse conciliare giustizia sociale e libertà personale.
Eppure, proprio quella manifestazione dell’8 marzo 1979 e l’immagine di Hengameh Golestan hanno lasciato un’eredità potente. Ogni volta che in Iran – come nel 2009, nel 2017 o nel 2022 – le donne tornano a protestare contro l’obbligo del velo o le leggi discriminatorie, quelle fotografie riappaiono, simbolo di una battaglia mai finita. È come se in quelle figure in bianco e nero, con il passo sicuro e lo sguardo fiero, si conservasse la memoria di un Iran diverso, più aperto, più complesso, che non ha mai smesso di esistere.